Il nuovo giro di vite di Pechino sulle esportazioni di terre rare non è un tecnicismo burocratico: è una scelta che parla di potere, di catene del valore e di sicurezza. Una mossa che sposta equilibri e costringe Washington e gli alleati a fare i conti con la realtà dei fornitori critici.
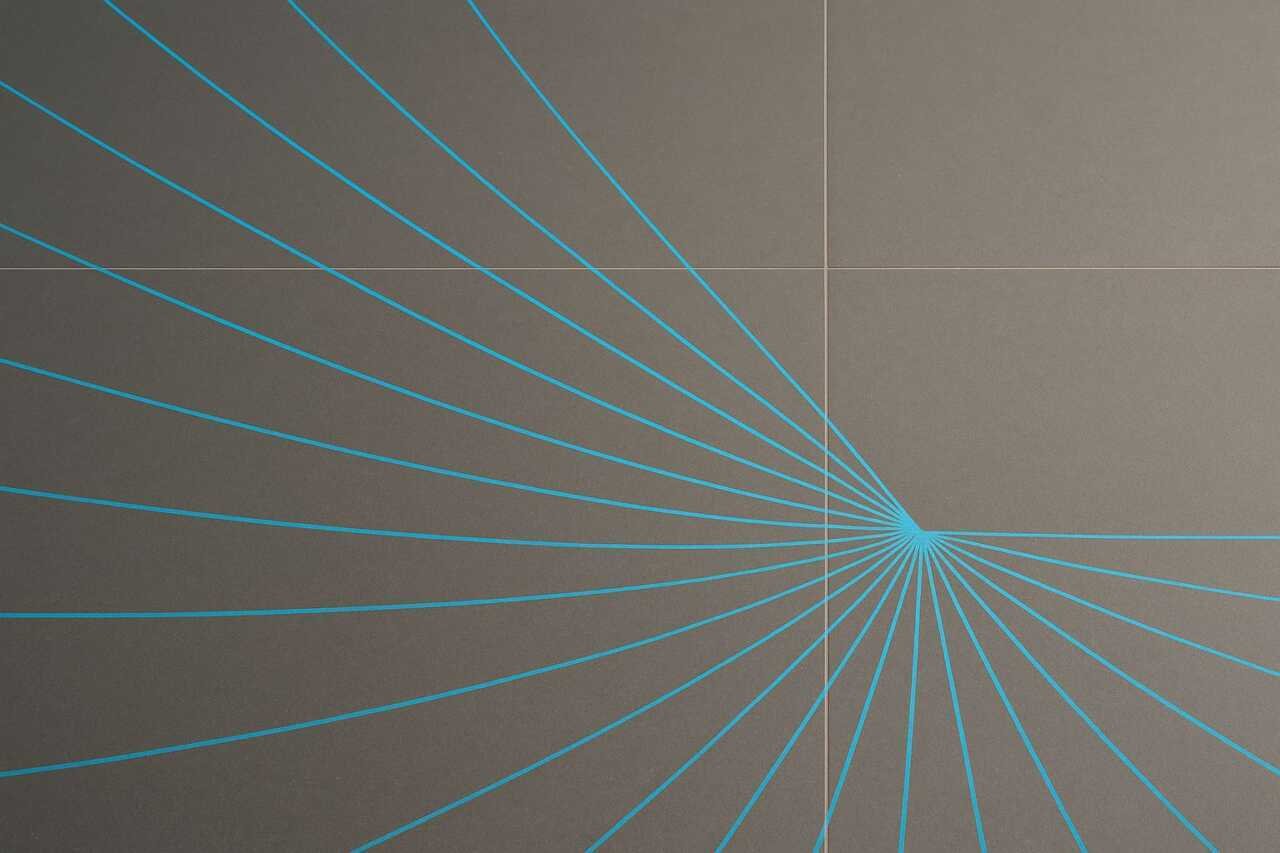
Un messaggio di potenza economica, non una formalità
La stretta cinese sulle terre rare scandisce un messaggio limpido: l’era in cui i controlli all’export erano prerogativa quasi esclusiva degli Stati Uniti è finita. La Cina ha ampliato la propria cornice di licenze e indicato che, in determinate circostanze, l’obbligo può toccare anche operatori stranieri che usino materiali o attrezzature cinesi, un’impostazione che richiama l’approccio extraterritoriale statunitense sugli export tecnologici. Lo hanno messo per iscritto le analisi legali sul regime 2025 e lo ha spiegato la cronaca internazionale, segnalando il parallelo con la prassi americana.
È altrettanto chiaro il registro politico con cui MOFCOM ha presentato la misura: prevenire usi illegali, fino all’eventuale impiego in armi di distruzione di massa, e tutelare la sicurezza nazionale, senza trasformare il sistema in un blocco indiscriminato. La portavoce He Yongqian ha promesso procedure più snelle e ha assicurato che le richieste “conformi” destinate a usi civili avranno il via libera, posizionando la licenza come filtro, non come muro. Queste parole sono state ribadite a ridosso dei nuovi annunci, precisando la volontà di facilitare il commercio legittimo.
Cosa cambia davvero: l’elenco degli elementi e le soglie fuori confine
Il 4 aprile 2025 un’ordinanza congiunta di Ministero del Commercio e Amministrazione Generale delle Dogane ha introdotto controlli di esportazione su un nucleo di terre rare medio‑pesanti: Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Lutezio, Scandio e Ittrio. La norma copre metalli, leghe, ossidi, composti e, per alcune voci, anche materiali magnetici, imponendo licenza e corretta indicazione doganale dei codici di controllo. Un quadro dettagliato, operativo dalla data di pubblicazione, che ha aggiornato il Catalogo cinese dei beni a duplice uso.
Il 10 ottobre 2025 Pechino ha esteso la rete aggiungendo altri elementi, tra cui Olmio, Erbio, Tulio, Europio e Itterbio, e ha colpito attrezzature e materiali di processo lungo l’intera filiera del raffinamento. L’applicazione prevede licenze più selettive verso usi difensivi e una valutazione più attenta in semiconduttori e intelligenza artificiale. Gli esperti hanno inoltre evidenziato soglie operative per magneti e target prodotti fuori dalla Cina se contengono anche quantità minime di determinati elementi o se sono realizzati con tecnologia cinese; le nuove regole, nella cornice comunicata dai portavoce, scattano da inizio novembre.
La risposta statunitense tra porti, tariffe e “liste”
Mentre la Cina rafforza le licenze sulle terre rare, Washington ha varato un pacchetto di misure in ambito Section 301 rivolto a navigazione, logistica e cantieristica: dopo 180 giorni a zero, dal 14 ottobre 2025 entrano in vigore service fees fino a 50 dollari per tonnellata di stazza netta per navi con operatori o proprietari cinesi, con incrementi negli anni successivi e un tetto di addebito annuale per singola nave. A ciò si aggiungono oneri su unità costruite in Cina calcolati per stazza o per container scaricato, oltre a interventi su attrezzature di banchina e rimodulazioni annunciate il 10 ottobre.
Sul fronte tecnologico la memoria corta non è un’opzione: il caso Huawei, inserita nella Entity List fin dal maggio 2019 con un regime che estende i divieti anche a prodotti esteri “derivati” da tecnologia statunitense, ha fatto scuola. È quello l’archetipo della extraterritorialità a stelle e strisce, poi ampliata con la foreign direct product rule nel 2020 per chiudere varchi di fornitura. La Cina, oggi, risponde con strumenti che riecheggiano quella logica, ma applicati ai minerali strategici e ai magneti permanenti.
L’equilibrio fragile delle catene del valore
La posta in gioco è industriale prima ancora che diplomatica. La Cina concentra oltre il 90% della produzione mondiale lavorata di terre rare e dei magneti ad esse collegati, ha ricordato la stampa internazionale, e questo rende più complessa l’idea di “derisking” prospettata in Occidente. L’IEA ha segnalato come, tra 2020 e 2024, la crescita del raffinato sia stata sempre più concentrata nei primi fornitori, con vulnerabilità persistentemente elevate. Non sorprende che a Washington i ministri del G7 abbiano convenuto sulla necessità di una linea comune e di fornitori diversificati.
L’area euro ha sperimentato quanto repentino possa essere lo shock: a maggio le spedizioni cinesi di magneti a base di terre rare verso l’Europa sono precipitate, costringendo alcuni costruttori a rallentare la produzione, secondo l’analisi dell’ECB. Nel frattempo, l’UE ha trasformato in legge il Critical Raw Materials Act, fissando obiettivi al 2030 su estrazione, raffinazione e riciclo e limitando al 65% la dipendenza da un singolo Paese per ogni stadio di processo; ambizione alta, percorso stretto.
Diplomazia in movimento: Madrid e il dopo‑Madrid
A metà settembre a Madrid delegazioni di Cina e USA hanno riaperto il canale del dialogo su tariffe, controlli all’export e il dossier digitale più sensibile. È in quel contesto che Pechino ha poi denunciato un’accelerazione di misure restrittive americane nelle settimane successive, sostenendo che l’ondata abbia compromesso l’atmosfera negoziale. La cornice dei colloqui spagnoli, confermata da fonti ufficiali, racconta una trattativa serrata ma ancora fragile.
Contestualmente, MOFCOM ha ripetuto che i nuovi controlli non prendono di mira un singolo Paese, che la licenza sarà lo strumento per distinguere usi civili da applicazioni sensibili e che l’amministrazione lavorerà per ridurre i tempi d’istruttoria, segnalando disponibilità a “facilitare” il commercio legittimo. Una linea riaffermata pubblicamente all’indomani delle critiche statunitensi.
Impatto industriale: magneti, elettronica, difesa
La lista cinese tocca il cuore di settori che tengono insieme transizione energetica e sicurezza: dai magneti permanenti ad alta coercitività per veicoli elettrici e eolico alle componenti per aerospazio ed elettronica di punta. Gli analisti hanno chiarito che le nuove licenze si applicano anche a produzioni estere che incorporano materiali o tecnologie cinesi, con rischi concreti per chi non si adegua: dalla possibile interruzione di forniture all’esclusione dai flussi di export. È un perimetro che spinge le imprese a ricalibrare subito compliance, tracciabilità e piani di sostituzione.
Mentre Bruxelles e Washington cercano alternative, negli Stati Uniti si muove l’industria: MP Materials ha avviato in Texas la produzione commerciale di metallo NdPr e la fase di test per magneti sinterizzati destinati all’automotive, un tassello della resilienza domestica, mentre Lynas ha segnalato incertezza su una prevista unità heavy rare earths in Texas. È la prova di quanto sia lungo costruire capacità industriale oltre la Cina.
Domande essenziali, risposte immediate
Quali elementi sono oggi sotto controllo cinese? La stretta ha preso le mosse il 4 aprile 2025 con sette terre rare medio‑pesanti: Samario, Gadolinio, Terbio, Disprosio, Lutezio, Scandio e Ittrio. Successivamente, il 10 ottobre, l’elenco è stato ampliato includendo, tra gli altri, Olmio, Erbio, Tulio, Europio e Itterbio. La copertura riguarda metalli, ossidi, composti, magneti e in alcuni casi attrezzature e materiali di processo, soggetti a licenza.
Quando entrano in vigore le nuove regole e con quali criteri? La prima tranche è operativa dalla pubblicazione del 4 aprile 2025; l’estensione comunicata a ottobre ha scadenze di attuazione fissate entro i primi di novembre. La linea dichiarata da MOFCOM distingue tra usi civili, per i quali le licenze “conformi” saranno approvate, e applicazioni sensibili, con attenzione particolare a difesa, semiconduttori e intelligenza artificiale.
Cosa devono fare le aziende fuori dalla Cina che usano materiali o macchinari cinesi? Devono mappare l’origine delle terre rare, dei magneti e delle apparecchiature di processo; verificare se ricadono in categorie controllate; predisporre tracciabilità documentale e, se necessario, richiedere licenza in Cina prima dell’export di prodotti finiti o semi‑lavorati. In assenza di conformità il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche di “taglio” dalle forniture cinesi lungo la catena.
Il “derisking” occidentale è in ritardo? L’Europa ha varato obiettivi al 2030 con il Critical Raw Materials Act su estrazione, raffinazione e riciclo, e ha fissato limiti alla dipendenza da un singolo Paese; ma gli stessi analisti energetici ricordano che la concentrazione nelle fasi di raffinazione resta elevata e scenderà lentamente. Il G7 si è impegnato a un fronte coordinato, segno che la strada è lunga e richiede investimenti e tempi industriali.
Una traiettoria che si decide adesso
Questa storia non è solo un confronto tra potenze: riguarda il telefono che teniamo in tasca, l’auto che guidiamo, la rete elettrica che alimenta le nostre città. Il modo in cui governi e imprese gestiranno le licenze, diversificheranno forniture, investiranno in tecnologie pulite e capacità di raffinazione dirà molto di come passeremo dall’annuncio all’azione. La tensione può salire, ma la politica industriale — quando è lucida — sa anticipare gli shock, non inseguirli.
Nel nostro lavoro di ogni giorno incrociamo dossier, aziende e scelte pubbliche: abbiamo imparato che le catene di fornitura non sono neutrali, sono il riflesso di priorità e valori. Riconoscere questa verità, senza enfasi e senza sconti, è il primo passo per fare informazione utile e per aiutare lettori e imprese a orientarsi in un mondo in cui le terre rare non sono più una questione da specialisti, ma una materia che tocca la vita di tutti.

